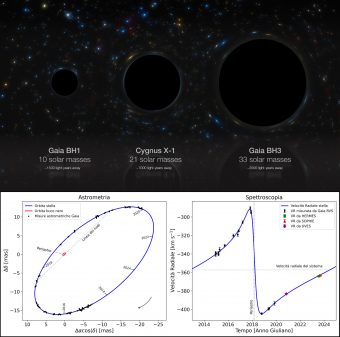Riportiamo il canovaccio della relazione tenuta dal direttore di “Eurasia” alla conferenza del centro studi internazionale Dimore della sapienza (Brescia 16 gennaio 2016)
Cercherò in primo luogo di delineare il profilo dello spazio geografico storicamente occupato dal popolo ungherese, perché lo spazio in questione ha influito e continua ancora ad influire sulla sorte storica di questo popolo.
Si tratta dello spazio che viene chiamato Bacino Pannonico (dal nome del popolo illirico che lo abitava nell’antichità) o Bacino dei Carpazi (dal nome della catena montuosa che lo delimita a nord e ad est).
Racchiuso tra le Alpi, i Carpazi e i Balcani, il Bacino Pannonico è la più vasta e la più chiusa tra le unità territoriali attraversate dal Danubio (le altre sono, ad ovest, lo spazio bavaro-svevo e quello della Bassa Austria; ad est, quello valacco-bulgaro). Il Bacino Pannonico non ha un litorale marino: è una vasta pianura che configura un settore di cerchio delimitato da massicci montani. Sembra che tutto il suo peso, poggiando sulle coste adriatiche e sulla regione balcanica, protegga o minacci l’Europa ed il Mediterraneo.
Infatti il Bacino Pannonico rappresentò una minaccia tra la fine dell’età antica e la prima metà del Medioevo, nel periodo delle “invasioni barbariche” (come vengono chiamate in Italia quelle che gli Ungheresi e i Tedeschi chiamano “migrazioni di popoli” (nelle rispettive lingue, népvándorlás e Völkerwanderung).
Goti, Gepidi, Unni, Avari e infine Ungari, in un primo momento fecero di questa fortezza naturale, collocata fra l’Oriente e l’Occidente, il punto di partenza delle loro scorrerie.
Non sto qui a rievocare la storia e le tappe della migrazione ungara prima dell’arrivo di questo popolo nel Bacino Pannonico. Basti dire che nell’anno di grazia 895 circa 200.000 cavalieri ungari accompagnati dalle loro famiglie, provenienti dalle pianure meridionali della Russia, valicarono il passo carpatico di Verecke. (Che oggi si trova in Ucraina; in memoria del passaggio degli Ungari vi sorge un monumento che è stato vandalizzato dagli sciovinisti ucraini nei giorni del golpe di Maidan). Gli Ungari dilagarono nella pianura solcata dal Tibisco e dal Danubio, abitata da tribù di varia appartenenza etnica. Questo evento, che gli Ungheresi chiamano “occupazione della patria” (honfoglalás) o “conquista della patria” (honhodítás), diede inizio alla nuova fase della loro storia.
Gli Ungari erano organizzati in dieci tribù, sette delle quali propriamente ugriche e tre cabarde (i Cabardi erano un popolo turco). Fra tutte, quella preminente era la tribù Magyar, il cui capo, Arpád, guidava l’intera comunità. E fu questa tribù ad estendere a tutto il popolo ungaro la denominazione di magyar, che gli Ungheresi usano ancora oggi.
Infatti Magyarország (lett. “paese magiaro”) è oggi, in base alla nuova Costituzione ungherese, la denominazione ufficiale dell’Ungheria.
Questa decisione non è piaciuta agli agguerriti critici della nuova Costituzione ungherese. Il “Corriere della Sera”, ad esempio, con sovrano sprezzo del ridicolo ha scritto che la denominazione Magyarország (“Ungheria”) in luogo di Magyar köztársaság (“Repubblica Ungherese”) richiama la “retorica di una grandeur nazionalistica che sembrava archiviata”.
Dicevo che il Bacino Pannonico rappresentò una minaccia per l’Europa dell’epoca. Nella prima metà del sec. X, infatti, gli Ungari intrapresero decine di spedizioni in varie parti d’Europa. Da Bisanzio ai Pirenei, gli Ungari seminavano il terrore, devastavano le campagne, espugnavano le città meno difese, catturavano bottino e prigionieri. “Nunc te rogamus, licet servi pessimi, – ab Hungarorum nos defendas jaculis”: così in Emilia si chiedeva a Dio la protezione contro le frecce dei cavalieri ungari. Identificati con gli Unni, gli Ungari erano visti come un secondo “flagello di Dio”; chi li diceva figli di diavoli e di streghe àvare, chi riconosceva in loro le genti di Gog e di Magog.
Con Enrico l’Uccellatore comincia però la riscossa dell’Europa cristiana contro le incursioni ungare. Il sovrano sassone, che in un primo tempo era stato costretto a versare il tributo agli Ungari per evitare i loro saccheggi, nel 933 li sconfigge in una battaglia campale. Nel 955 suo figlio Ottone I sbaraglia di nuovo nel Lechsfeld l’orda ungara che aveva assalito Augusta (Augsburg).
In seguito alla sconfitta, gli Ungari avvertono la necessità di cambiare rotta, instaurando rapporti di buon vicinato con il Sacro Romano Impero, rinunciando definitivamente al seminomadismo ed alle incursioni e insediandosi stabilmente nel bacino carpatico-danubiano.
Per compiere questa svolta, gli Ungari devono legittimarsi, abbandonando la religione dei padri (una forma di sciamanesimo affine a quello dei Finni e dei Turchi) e adottando quella cristiana. Il principe Taksony chiede alla Santa Sede di inviare un vescovo tra gli Ungari; il suo successore Géza si fa battezzare; il figlio di Géza, Vajk, assume il nome cristiano di Stefano, nell’anno 1000 riceve la corona d’Ungheria da papa Silvestro II e prosegue decisamente nell’opera di conversione delle tribù ungare.
I barbari predatori diventano le sentinelle dell’Europa sul confine orientale. Se il limes dell’Impero Romano era segnato ad est dal corso del Danubio, dopo il 1000 il limes orientale dell’Europa medioevale è rappresentato dal regno d’Ungheria.
L’Ungheria diventa così un antemurale Christianitatis contro gli attacchi provenienti da oriente.
In seguito, tre imperi si sarebbero affrontati per controllare lo spazio solcato dal Danubio: l’impero absburgico, l’impero ottomano e quello russo, ciascuno seguendo una diversa direzione di marcia. Gli Austriaci discesero il fiume, i Turchi lo risalirono, l’Armata Rossa lo attraversò.
Nell’impero absburgico, che controllò buona parte dello spazio danubiano fino alla prima guerra mondiale, il centro di gravità non era occupato dai Tedeschi, ma dalla massa compatta degli Ungheresi. L’Ungheria costituiva il nerbo dell’impero: nel centro geometrico della Monarchia absburgica, al centro del bacino danubiano, c’erano Buda e Pest, mentre Vienna si trovava alla periferia, vicino al confine occidentale. Periferici erano anche gli altri territori: Transilvania, Bosnia, Carinzia, Stiria, Slovacchia, Boemia, Galizia. Sulla carta geografica, la Monarchia danubiana appariva come un’Ungheria prolungata verso il nord e verso l’ovest.
È questo lo sfondo geopolitico del Compromesso (Ausgleich, Kiegyezés), la riforma costituzionale del 1867, che Vienna si vide costretta ad adottare in seguito alla sconfitta subita nella guerra austro-prussiana dell’anno precedente, riconoscendo al blocco compatto degli Ungheresi un peso decisivo. In virtù del Compromesso, l’Impero d’Austria diventava una “monarchia austro-ungarica”: una duplice monarchia che, sotto un identico sovrano (Imperatore d’Austria e Re d’Ungheria), si articolava in due regni distinti. Se i ministeri competenti per la politica estera, la politica economica e quella militare erano in comune, accanto all’imperial-regio esercito esistevano anche un esercito nazionale austriaco (Landwehr) e un esercito nazionale ungherese (Honvéd), mentre le questioni finanziarie e quelle commerciali erano regolate da accordi decennali rinnovabili.
Gli Ungheresi non erano solo il popolo centrale del bacino danubiano, ma erano anche l’unico che apparteneva soltanto ad esso, l’unico la cui lingua non era parlata da nessun’altra parte. La patria degli Ungheresi (come d’altronde quella dei Cechi, degli Slovacchi, degli Sloveni e dei Croati) si trovava tutta quanta entro i confini della Monarchia absburgica, mentre altri popoli (i Tedeschi, i Serbi, i Romeni, gli Ucraini, i Polacchi, gl’Italiani) erano insediati in parte entro i confini absburgici e in parte fuori.
Non è corretto formulare delle ipotesi circa sviluppi storici che non si sono verificati; tuttavia si è inevitabilmente tentati di dire che l’Austria-Ungheria sarebbe diventata una Grande Ungheria, se la prima guerra mondiale non avesse posto fine all’esistenza dell’impero, riducendo inoltre l’Ungheria ai minimi termini.
Tutti sappiamo quali effetti devastanti sono stati prodotti – con conseguenze che durano fino ai giorni nostri – dai trattati di pace che vennero imposti agli sconfitti della prima guerra mondiale.
Per quanto riguarda in particolare l’Ungheria, essa pagò a carissimo prezzo la distruzione dell’Impero asburgico.
I confini dello Stato ungherese, fissati dal Trattato del Trianon il 4 giugno 1920, privavano l’Ungheria di circa due terzi del suo territorio e della sua popolazione.
Nelle province che l’Ungheria dovette cedere ad altri Stati la popolazione apparteneva per lo più ad etnie non ungheresi (Slavi e Romeni soprattutto); in certi casi, però, essa includeva significative minoranze ungheresi, mentre in alcuni territori c’era addirittura una maggioranza ungherese.
Secondo i dati del censimento del 1910 la popolazione ungherese in Transilvania ammontava a 1.662.000 individui (32%), in Slovacchia a 885.000 (30%), nella Rutenia subcarpatica, passata all’Ucraina, a 183.000 (30%), nella Voivodina, passata alla Jugoslavia, a 420.000 (28%), nel Burgenland, passato all’Austria, a 26.200 (9%), in Croazia a 121.000 (3,5%), in Slovenia a 20.800 (1,6%).
Per effetto del Trattato del Trianon la popolazione ungherese diminuì in tutte queste regioni; tuttavia notevoli minoranze ungheresi vi risiedono ancora oggi, specialmente in Romania, in Slovacchia, in Serbia ed in Ucraina.
Come si disse all’epoca con un amaro umorismo, l’Ungheria era diventata l’unico paese al mondo che confinasse con se stesso da ogni lato. A questa boutade se ne aggiungeva un’altra: l’Ungheria, oltre ad essere una monarchia senza re, era un paese senza mare guidato da un ammiraglio. Infatti il nuovo staterello ungherese non ebbe più nessun accesso al mare, mentre per oltre 800 anni il Regno d’Ungheria si era affacciato sull’Adriatico.
Nacque allora un neologismo che oggi è passato a indicare tutt’altra cosa: revisionismo. Tale termine indicava la richiesta ungherese di sottoporre a revisione il Trattato del Trianon, richiesta che venne appoggiata da quegli Stati che erano stati anch’essi in vario modo penalizzati dai trattati di pace, in primis la Germania e l’Italia.
Dell’avvicinamento a Roma e a Berlino l’Ungheria raccolse i frutti il 30 agosto 1940, quando i ministri degli esteri del Reich e dell’Italia, Joachim von Ribbentrop e Galeazzo Ciano, emisero a Vienna una decisione arbitrale che restituiva a Budapest una parte dei territori assegnati alla Romania (la Transilvania del nord).
Poi però, in seguito alla vittoria delle potenze alleate, l’Ungheria, alleata dell’Asse, uscì dal secondo conflitto mondiale con gli stessi confini stabiliti dal Trattato del Trianon. e per quarant’anni fece parte dello spazio geopolitico egemonizzato dall’URSS.
Ma fu proprio l’Ungheria, il 23 agosto 1989, che iniziò a smantellare la Cortina di Ferro, favorendo l’esodo di migliaia di Tedeschi dalla DDR. Con la caduta del Muro di Berlino e della Cortina di Ferro, con lo scioglimento del Patto di Varsavia, la dissoluzione dell’URSS e il rovesciamento del sistema comunista, l’Ungheria si orientò verso i modelli economici e politici dell’Europa occidentale, cosicché nel 1989 la Repubblica Popolare Ungherese (Magyar Népköztársaság) cessò di esistere.
Qualche anno più tardi, nel maggio 1995 (dopo la vittoria elettorale dei socialisti e la loro alleanza coi liberaldemocratici) si tenne a Budapest l’assemblea parlamentare della NATO. L’Ungheria non era ancora un paese membro dell’Alleanza Atlantica, però aveva aderito al “Partenariato per la Pace” creato dalla NATO nel 1994 ed aveva dato l’assenso all’allestimento di una base militare statunitense a Taszár, nelle vicinanze della frontiera bosniaca.
Fu solo nel marzo 1999, all’epoca del primo governo Orbán (1998-2002), che l’Ungheria entrò ufficialmente a far parte dell’organizzazione militare atlantica e, in quanto tale, prese parte alla missione della NATO in Afghanistan (l’ISAF) ed alla guerra in Iraq, stanziandovi 300 militari ufficialmente non impegnati in operazioni di combattimento.
Chi era il Primo Ministro Viktor Orbán?
Nato nel 1963 a Székesfehérvár, non lontano da Budapest, da una famiglia d’origine transilvana di confessione calvinista, Viktor Mihály Orbán aveva fondato nel 1988 l’Alleanza dei Giovani Democratici, in ungherese Fiatal Demokraták Szövetsége, da cui l’acronimo Fidesz (che suona all’orecchio come l’omofona parola latina). Si trattava di una formazione liberale e progressista, impegnata sul tema dei diritti civili.
Nel 1990, quando Orbán entra in Parlamento, il Fidesz è schierato all’opposizione, contro il governo di centrodestra presieduto da József Antall, esponente del Forum Democratico Ungherese (Magyar Demokrata Fórum), formazione affiliata al Partito Popolare Europeo.
Nel 1994, allorché i socialisti vincono le elezioni e si alleano coi liberaldemocratici, Orbán si schiera di nuovo all’opposizione, con un Fidesz che, da liberale e progressista che era, si è spostato nel campo del centrodestra. Prima di morire (nel 1993), Antall ha investito Orbán della sua eredità politica, convincendolo ad abbandonare le posizioni precedenti. Alcuni membri del Fidesz non hanno accettato la svolta e hanno dato le dimissioni dal partito, ma la maggioranza ha seguito Orbán, che negli anni passati all’opposizione consolida il suo nuovo profilo politico.
Dopo aver presieduto il suo primo governo (fra il 1998 e il 2002, come si è detto), Orbán dovette cedere il passo ad una coalizione di centrosinistra guidata da un banchiere, Péter Medgyessy. Si parlò allora di una vendetta dei “poteri forti” contro il governo di Orbán, che aveva concesso prestiti a fondo perduto ai cittadini bisognosi di costruirsi una casa. La stampa ungherese, controllata da Soros e da Murdoch, aveva scatenato una campagna contro Orbán, accusandolo tra l’altro di essersi alleato con il Partito Ungherese della Giustizia e della Vita (Magyar Igazság és Élet Pártja), fondato dal drammaturgo István Csurka e bollato come “antisemita”.
Al governo di Medgyessy seguirono quello di Ferenc Gyurcsány, “il socialista in limousine”, travolto da uno squallido scandalo, e poi quello di Gordon Bajnai, anche quest’ultimo fortemente impopolare, poiché, per accedere al prestito del Fondo Monetario Internazionale, ridusse ai minimi termini le spese di carattere sociale.
Nel 2010, Orbán va al governo una seconda volta, con la maggioranza parlamentare più solida affermatasi in Ungheria dopo la caduta del regime comunista (263 seggi su 386).
Durante questo secondo mandato, che dura fino al 2014, entra in vigore (il 1 gennaio 2012) la nuova Costituzione.
Il Preambolo della nuova carta costituzionale riconosce un valore fondante alla rivolta del 1956, valorizzandone non gli elementi riformisti e “di sinistra” (quelli rappresentati dall’ultimo governo di Imre Nagy, abbattuto dalla repressione sovietica), ma gli aspetti civici e nazionali.
(D’altronde, la lettura della rivolta del 1956 fatta da Orbán e dai suoi ricalca, senza citarlo, il discorso radiofonico fatto dal Cardinale Mindszenty appena scarcerato. “Questa non è una rivoluzione, ma una lotta per la libertà”, disse allora il Cardinale, volendo sottolineare l’aspetto nazionale dell’insurrezione).
Essendo dunque di orientamento nazionale e conservatore, la nuova Costituzione ungherese, pur essendo stata approvata dai due terzi del Parlamento, è stata bollata in Occidente come antidemocratica e liberticida. Tra le personalità di governo che l’hanno attaccata, forse la più violenta è stata la segretaria di Stato nordamericana.
In particolare, la nuova Costituzione ha suscitato le critiche delle istituzioni comunitarie europee. L’Ungheria era entrata nell’Unione Europea il 1° maggio 2004, sperando, tra l’altro, che tale adesione potesse servire a risolvere i problemi inerenti alle frontiere istituite dal Trattato del Trianon.
Infatti lo smembramento dell’Ungheria avvenuto col Trattato del Trianon è un motivo presente nella nuova Carta costituzionale ungherese, che nel Preambolo dichiara: “Promettiamo di custodire l’unità spirituale e morale della nostra Nazione, andata in pezzi nelle tempeste del secolo scorso”. Su questo punto della Costituzione si fonda l’estensione della cittadinanza ungherese, col relativo diritto di voto, ai connazionali che sono cittadini dei paesi confinanti.
Andando per ordine, il primo punto della Costituzione che è stato contestato in Occidente è il riferimento a Dio ed alla religione, per cui si è addirittura parlato di una ispirazione “clericale” e di un progetto “teocratico”. E questo perché il testo costituzionale si apre con l’invocazione “Dio, benedici l’Ungherese!” (Isten, áldd meg a Magyart); è il verso iniziale dell’Inno di Ferenc Kölcsey (1790-1838), la poesia che, musicata da Ferenc Erkel, è diventata inno nazionale; un inno che viene cantato anche in chiesa al termine della messa.
(Detto per inciso: si potrebbe replicare che anche l’inno nazionale italiano, evocando una Vittoria poeticamente personificata, dice che “schiava di Roma – Iddio la creò”. D’altronde non risulta che i critici del presunto carattere clericale della Costituzione ungherese, a cominciare dalla signora Clinton, abbiano rivolto critiche analoghe in relazione agli Stati Uniti, dove il presidente termina spesso i suoi discorsi con la frase “God bless America!” e dove le banconote recano la scritta “In God we trust“).
Ma non si tratta solo del verso dell’Inno di Kölcsey. Nel Preambolo della Costituzione, intitolato Professione di fede nazionale, si legge: “Siamo fieri del fatto che mille anni fa il nostro re Santo Stefano abbia collocato lo Stato ungherese su solide fondamenta ed abbia reso la nostra patria parte dell’Europa cristiana”. E più avanti: “Riconosciamo il ruolo di conservazione della nazione svolto dal cristianesimo”. Tali affermazioni sono state giudicate contrarie ai valori di laicità ai quali si ispira l’Unione Europea e sono sembrate discriminatorie nei confronti dei fedeli di altre religioni.
In realtà, una tale accusa è smentita dal fatto che lo stesso testo costituzionale riconosce il carattere multiconfessionale dell’Ungheria, laddove dichiara: “Rispettiamo le diverse tradizioni religiose del nostro paese”.
A questo proposito vale la pena di ricordare che la nuova legge sulle confessioni religiose, in applicazione del dettato costituzionale, garantisce il riconoscimento dello Stato a 14 comunità religiose: più di quelle con cui la Repubblica Italiana ha stipulato un concordato o un’intesa. Bisogna anche aggiungere che, prima che venisse emanata questa legge, le organizzazioni religiose, parareligiose e pseudoreligiose sovvenzionate col denaro pubblico erano ben 300. Era sufficiente raccogliere un centinaio di firme e chiunque poteva aspirare ad incassare, a nome della propria “chiesa”, l’uno per cento del reddito dichiarato dai contribuenti. Contrariamente a quanto la propaganda dirittumanista vorrebbe far credere, tutte queste organizzazioni non sono state interdette, ma sono diventate semplici associazioni private.
Un altro articolo costituzionale che ha provocato notevole sconcerto fra i sostenitori dei “diritti umani” è l’articolo L (prima parte della Carta), che definisce il matrimonio come “comunione di vita (életközösség) tra uomo e donna”.
In un rapporto del 31 marzo 2011 Amnesty International giudica particolarmente problematico il fatto che la nuova Costituzione non interdica la discriminazione fondata sugli orientamenti sessuali. Al Parlamento europeo l’Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa (che riunisce varie formazioni politiche) ha protestato contro questo articolo, che, a loro dire, discrimina le coppie omosessuali “sulla base di specifici valori come la fede, la lealtà, la preminenza della comunità e della nazione sull’individuo”.
Nella seconda parte del testo costituzionale, che concerne diritti e doveri dei cittadini, ha suscitato analoga riprovazione l’articolo II, il quale afferma che la vita umana è protetta fin dal momento in cui viene concepita. Si è sostenuto che tale articolo violerebbe i valori europei; in realtà, esso è perfettamente conforme al principio del diritto romano secondo cui “infans conceptus pro nato habetur” (“il bambino concepito è considerato come nato”).
Tralasciando le altre accuse che gli alfieri dei “diritti umani” rivolgono alla nuova Costituzione, si può osservare che quest’ultima tocca i vertici dell’eterodossia laddove rimanda all’attività del legislatore l’attuazione di una disposizione concernente la Banca Centrale Nazionale, ispirando una serie di riforme costituzionali che mirano a sottrarre beni e risorse al controllo degli speculatori internazionali ed a riportarli nelle mani degli Ungheresi.
Veniamo ora al terzo governo di Orbán, quello attualmente in carica.
Nelle elezioni politiche dell’aprile 2014 il Fidesz ha ottenuto il 44,5% dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi. Ricevuto per la terza volta l’incarico di formare un governo, Orbán ha assunto posizioni politiche che gli hanno attirato pesanti critiche e condanne. Per esempio, ha fatto scandalo la sua dichiarazione di non ritenere più adatta la forma occidentale di democrazia liberale e di ritenere necessario “liberarsi dai dogmi” ideologici.
Per quanto riguarda le relazioni dell’Ungheria con gli altri paesi europei, Orbán ha rilanciato il cosiddetto “gruppo di Visegrád”, che si era costituito nel 1991 in seguito ad un vertice dei capi di Stato e di governo di Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia.
(Nella città ungherese di Visegrád, 650 anni prima, Carlo I d’Ungheria, Casimiro III di Polonia e Giovanni I di Boemia avevano concordato sulla necessità di creare nuove vie commerciali che, evitando il centro di Vienna, ottenessero accessi più veloci ai diversi mercati europei).
L’incontro del 1991 si era svolto per stabilire e rafforzare la cooperazione fra questi tre Stati – Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia (diventati quattro il 1º gennaio del 1993 con la divisione consensuale della Cecoslovacchia), allo scopo di promuovere l’integrazione unitaria del gruppo nell’Unione Europea.
Fallito questo tipo di approccio, si passò presto a rapporti diretti tra Bruxelles e i singoli Stati candidati, che entrarono nell’Unione Europea il 1º maggio 2004.
Adesso l’Ungheria, insieme con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, forma un’alleanza che intende rafforzare la politica degli Stati nazionali all’interno dell’Unione Europea.
Il giorno dell’Epifania, Orbán ha incontrato Jaroslaw Kaczynski, presidente del più forte partito politico della Polonia, il Partito Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość), di ispirazione conservatrice.
Siccome il governo polacco è attualmente accusato di violare lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e la libertà di stampa e la coalizione di governo tedesca (stando alla Deutsche Presse-Agentur) considera l’ipotesi di introdurre sanzioni contro il governo di Varsavia, Orbán ha dichiarato pubblicamente che Budapest non permetterà mai all’Unione Europea di punire la Polonia.
Ora, la solidarietà ungherese verso la Polonia cozza con l’atteggiamento russofobico della Polonia. Se fino ad alcuni mesi fa il partito di Kaczinski accusava Orbán di “agire contro l’unità dell’Unione Europea con le sue relazioni con la Russia”, adesso il nuovo governo polacco si deve difendere dagli attacchi provenienti da ovest e deve contare sulla solidarietà ungherese, per cui, presumibilmente, sarà costretto ad attenuare la sua russofobia.
Orbán, infatti, ha allacciato stretti legami con la Russia e con la Cina, soprattutto per quanto riguarda il settore energetico, ma non solo: da quest’anno la televisione ungherese di Stato trasmetterà quotidianamente un notiziario in lingua cinese, dedicato alle decine di migliaia di Cinesi che vivono e lavorano in Ungheria. Il telegiornale in cinese andrà in onda subito dopo quello in russo.
Per quanto concerne le relazioni che il governo di Orbán intrattiene con la Russia, la Russia è il primo interlocutore commerciale dell’Ungheria fuori dall’Unione Europea. Inoltre l’Ungheria ha siglato con la società russa Rosatom un accordo da 10.000 milioni di dollari per la costruzione di un reattore atomico di 2000 megawatt.
Si capisce così perché un paio d’anni fa il “Washington Post” abbia paventato il rischio che l’Ungheria possa diventare un avamposto della Russia e perché il senatore statunitense John Mc Cain, noto per la sua russofobia, abbia criticato pesantemente le relazioni dell’Ungheria con la Russia, definendo il Primo Ministro ungherese nientemeno che “un dittatore neofascista” e provocando una crisi diplomatica tra Washington e Budapest.
Mc Cain aveva detto testualmente: “L’Ungheria si trova sul punto di cedere la sua sovranità ad un dittatore neofascista che va a letto con Vladimir Putin”.
Liquidando le parole di Mc Cain come “manifestazioni di estremismo”, Orbán dichiarò: “In questo momento l’indipendenza nazionale dell’Ungheria si trova sotto attacco. (…) L’indipendenza dell’Ungheria in termini di energia, di finanze e di relazioni commerciali dà fastidio a coloro che prima del 2010 hanno tratto vantaggio dalla dipendenza del nostro Paese”.
In tutta la sua storia, dalla “conquista della patria” fino ad oggi, la nazione ungherese si è trovata a metà strada fra l’Oriente, da cui essa era provenuta, e l’Occidente europeo, nel quale si era venuta ad inserire.
Ha dovuto scegliere – e a volte sono stati altri a scegliere per lei – tra le steppe e la pianura danubiana, tra lo sciamanesimo e il cristianesimo, tra Bisanzio e Roma, tra il cattolicesimo e la Riforma protestante, tra l’impero ottomano e quello absburgico, tra il Patto di Varsavia e l’Alleanza Atlantica.
Oggi il problema di una scelta non si pone, quanto meno per ora; nonostante le divergenze e le polemiche, nonostante l’insofferenza degli Ungheresi per le istituzioni comunitarie, l’Ungheria fa parte dell’Unione Europea.
Però quattro anni fa, nel periodo più caldo dello scontro che oppose il governo di Budapest alle istituzioni di Bruxelles Orbán si lasciò sfuggire questa frase: “C’è vita anche fuori dall’Unione Europea” o “Si può vivere anche fuori dall’Unione Europea”.
Poco dopo, Orbán ha compì una visita di due giorni in Kazakistan, nel corso della quale dichiarò: “Gli Ungheresi hanno capito presto quello che i dirigenti dell’Unione Europea sono riluttanti ad accettare ed accettano con grande difficoltà. Noi non possiamo continuare a vivere come abbiamo vissuto finora”.
Secondo il capo del governo ungherese, il centro di gravità del potere mondiale si sta spostando verso Oriente, perciò l’Ungheria vuole aprirsi alle economie orientali; la visita del primo ministro ungherese ad Astana fu presentata come un evento importante nel processo di apertura dell’Ungheria all’Asia.
A caldeggiare un più stretto rapporto dell’Ungheria con l’Oriente, in particolare con quelli che i Magiari considerano “popoli affini”, non sono soltanto il governo di Viktor Orbán e la coalizione conservatrice che lo sostiene. L’opposizione di destra, rappresentata dal “Movimento per un’Ungheria migliore” (Mozgalom egy jobbik Magyarországért, detto correntemente Jobbik), esprime posizioni sostanzialmente analoghe, ma formulate in termini più radicali. Tre anni fa su un numero di “Barikád” apparve un articolo di Gábor Vona, il presidente di Jobbik, che recava un titolo esplicito ed eloquente: “Eurasiatismo, anziché euroatlantismo!” (Euroatlantizmus helyett eurázsianizmust!).
“Al mondo – scriveva Vona – ci sono 300 milioni di uomini che si identificano come appartenenti a popoli turanici. Questi popoli si domandano con stupore come mai noi Ungheresi non coltiviamo come dovremmo questa nostra eredità. È un fatto sostanziale che questa fascia turanica, che dall’Ungheria si estende fino alla Cina, oggi costituisce uno degli scacchieri più importanti, se non il più importante, della politica mondiale. Essa possiede gran parte delle riserve di gas naturale e di petrolio della terra, per cui la sua rilevanza geopolitica non può essere esagerata. Se stabilisse un’alleanza con questa compagine, l’Ungheria potrebbe uscire dalla sua attuale condizione coloniale ed acquisire un ruolo nella politica mondiale”.
Vona sostiene che solo una “svolta ad Oriente” o una “apertura ad oriente” potrebbe far uscire l’Ungheria dalla situazione disperata attuale, dovuta ad un asimmetrico rapporto con l’Occidente. L’Ungheria non può affidarsi all’Unione Europea, se vuole rimettere in piedi l’agricoltura, l’industria alimentare e quella manifatturiera, ma deve puntare sull’apertura di prospettive eurasiatiche (eurázsiai távlatok).
C’è tutta una serie di argomenti, conclude l’esponente di Jobbik, che impone all’Ungheria una scelta di campo geopolitica, riassumibile nella parola d’ordine di Pál Teleki, che fu primo ministro dal 1920 al 1921 e poi dal 1939 al 1941: “A oriente, Ungherese!” (Keletre, magyar!). Gábor Vona ripete l’esortazione di Teleki ed aggiunge: “Diamogli ascolto!”
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()